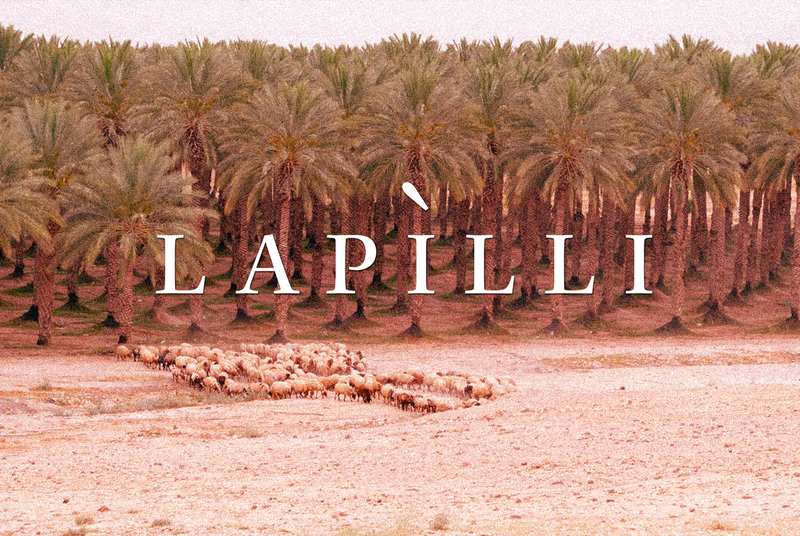In questa edizione di Lapilli ci concentriamo sulla terra e su come possa venire fortemente impattata dalla guerra e dai cambiamenti climatici - fenomeni estremi, scarsità d’acqua, aumento delle temperature. Ci soffermiamo in particolare sull’agricoltura e sul doppio filo che la lega alla crisi climatica: fonte di emissioni da un lato e vittima dall’altro. Cerchiamo poi di mettere in risalto alcuni modi di rapportarsi alla terra che possono contribuire a invertire la rotta e aiutarci a ritrovare una maggiore sintonia col pianeta. Infine, segnaliamo un paio di recenti avvistamenti di foca monaca in Sicilia, una piccola anticipazione di quanto affronteremo nel prossimo numero di Lapilli+.
Inoltre, vorremmo conoscere meglio i nostri lettori! Se disponibile a condividere con noi cosa ti piace e cosa ti aspetti da questo progetto, puoi lasciarci i tuoi contatti a questo link: in cambio di non più di un'ora del tuo tempo, ti offriamo un anno di Lapilli premium.

Gaza devastata. Mentre si decidono le sorti della Striscia di Gaza, un articolo apparso su Yale E360 a inizio febbraio racconta la grave crisi ambientale in cui versa la Striscia dopo 15 mesi di bombardamenti e di conflitto.
Le immagini satellitari scattate dopo il recente cessate il fuoco mostrano l'entità della devastazione: 80 percento di alberi in meno; danni a zone umide, dune di sabbia, acque costiere e all'unico fiume significativo della regione, il Wadi Gaza. Il Programma per l'ambiente delle Nazioni unite avverte che la distruzione diffusa di alberi, arbusti e colture ha degradato così gravemente il suolo che Gaza rischia ora una desertificazione a lungo termine.
Oltre a mettere fuori uso infrastrutture essenziali per la fornitura d'acqua e il trattamento delle acque reflue, la guerra ha anche danneggiato o distrutto più di due terzi dei terreni agricoli, compresi pozzi e serre, nonché il 74 percento degli uliveti. Nel frattempo, i palestinesi sfollati fanno ricorso al fango per costruire rifugi più stabili per le loro famiglie (The New Arab via Egab).
Agricoltori svizzeri fanno causa al governo. Un recente articolo pubblicato su Nature racconta come in Svizzera un gruppo di agricoltori abbia fatto causa al governo per non aver intrapreso azioni sufficienti per fronteggiare i cambiamenti climatici. Nel marzo dello scorso anno, nove agricoltori e cinque associazioni di categoria, prove alla mano, hanno sostenuto di aver perso tra il 10 e il 40 percento del loro fatturato annuale negli ultimi tre anni a causa di siccità, caldo, tempeste, grandine e altri impatti dei cambiamenti climatici. Gli agricoltori dietro l’iniziativa accusano il governo di non stare facendo abbastanza per salvaguardare il loro sostentamento e la sicurezza alimentare. La Svizzera infatti si è già surriscaldata di 2,8 gradi rispetto alla media preindustriale. E mentre molti agricoltori contestano le recenti politiche climatiche di Svizzera e Unione europea (Ue), altri - come quelli coinvolti nella causa - chiedono azioni più coraggiose per proteggere il proprio futuro.
L’assalto delle locuste ai datteri della Libia. Un esempio dell'impatto che i cambiamenti climatici possono avere sull'agricoltura viene dalla Libia. Secondo un articolo uscito su El País (via Egab), negli ultimi mesi le regioni orientali, meridionali e occidentali del paese nordafricano sono state devastate da sciami di locuste del deserto. La piaga ha colpito in modo particolare una delle colture di maggior valore commerciale del paese, la palma da dattero. Un esperto intervistato nell’articolo ha collegato l'epidemia alle piogge torrenziali che hanno inondato il deserto del Sahara lo scorso autunno, creando laghi e pozze d'acqua che avrebbero formato un ambiente ideale per la riproduzione delle locuste. Secondo l’esperto, uno sciame può consumare più cibo in 24 ore di 2mila persone: ogni locusta infatti arriva a mangiare circa due grammi di vegetazione al giorno.

Chi custodisce la biodiversità dei semi? Secondo l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni unite, oltre il 75 percento della diversità genetica delle piante è andato perduto a livello globale a causa del passaggio a un’agricoltura industriale ad alta resa, controllata da poche multinazionali. In Europa, festival dedicati ai semi come quello di Peliti, in Grecia, e banche come la Plant Genetic Resource Bank di Buzău, in Romania, contribuiscono a preservare varietà di colture selezionate dai contadini nel corso dei secoli. Molti pensano che questi semi potrebbero essere la chiave per un futuro più resiliente, burocrazia e regolamenti dell'Ue permettendo (Unbias the News).
Una nuova generazione di pastore. Abbiamo dedicato l'ultima edizione di Lapilli+ alla gestione delle foreste, selezionando brani da un recente libro sulle montagne italiane. Qui segnaliamo invece un'altra storia che parla sempre di montagne e che abbiamo trovato su Internazionale. In questo caso le protagoniste sono giovani donne che hanno scelto di fare le pastore sugli Appennini o sulle Alpi Apuane. Una tendenza che non sembra limitata all'Italia: molti ricorderanno il lavoro della fotografa Paroma Basu sulle pastore in Spagna uscito sul Guardian lo scorso anno. Internazionale sottolinea come il 28 percento degli imprenditori agricoli italiani siano donne e riporta l'alto numero di domande di iscrizione ricevute dalla scuola che forma pastori sull'Appennino tosco-emiliano. Una scelta che, secondo quanto affermato dalle pastore intervistate, spesso nasce da un forte desiderio di libertà.


Ghiacciai che svaniscono. Sempre in tema montano, un recente studio pubblicato su Nature stima che tra il 2000 e il 2023 i ghiacciai dell'Europa centrale hanno perso il 39 percento del loro volume. La ricerca si concentra per lo più sul piano globale sottolineando come i ghiacciai del mondo abbiano perso collettivamente 6,542 trilioni di tonnellate di ghiaccio nei 23 anni oggetto dello studio, ovvero circa il 5 percento del loro volume, contribuendo a un aumento del livello del mare di 18 millimetri (The Guardian; Rsi).
Le ripercussioni della scarsità d'acqua sulla vita marina. Un altro studio uscito su Nature Communications ci avverte invece che un clima più caldo di 4 gradi rispetto al periodo preindustriale potrebbe ridurre del 41 percento la quantità di acqua dolce che affluisce nel mar Mediterraneo. Questo potrebbe portare a una diminuzione del 10 percento della produttività marina e del 6 percento della biomassa, causando 4,7 miliardi di euro di perdite annuali per l'industria della pesca, oltre a gravi impatti sulle comunità costiere. Secondo lo studio, l'Adriatico e il mar Egeo, due tra le aree più sfruttate dalla pesca, potrebbero essere le più colpite.

Scadenze mancate. Solo tre paesi tra quelli che puntellano il bacino del Mediterraneo hanno rispettato la scadenza per presentare i propri impegni climatici per il 2035: Svizzera, Andorra e Montenegro. I maggiori emettitori di gas climalteranti della regione, come la maggior parte delle nazioni al mondo, hanno perso l'opportunità di dimostrare il loro impegno nel limitare il riscaldamento globale entro i 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali sancito nel 2015 a Parigi. In base all'accordo, i paesi firmatari devono presentare ogni cinque anni dei rapporti aggiornati che indichino i propri piani per tagliare le emissioni a livello nazionale e adattarsi agli impatti climatici (Materia rinnovabile; Carbon Brief).
Un'isola allagata. Il 13 febbraio un potente nubifragio si è abbattuto sull'Italia centrale, colpendo in particolare alcune zone della Toscana. Forti acquazzoni hanno colpito Portoferraio, il capoluogo dell'isola, allagando soprattutto i quartieri più bassi (Il Tirreno). In provincia di Grosseto, le acque hanno interrotto le strade tra Orbetello e Albinia, lasciando isolate molte abitazioni (La Nazione). La tempesta ha anche causato un notevole deflusso di sedimenti, con grandi quantità di detriti che si sono riversati dai fiumi della regione nel mar Mediterraneo, come chiaramente visibile in un'immagine satellitare acquisita il 16 febbraio 2025 da Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea.

Avvistamenti insoliti. Ci salutiamo con alcuni avvistamenti degni di nota. Il primo è avvenuto a fine febbraio al largo di Taranto dove i ricercatori della Jonian Dolphin Conservation hanno filmato una balenottera comune, animale che non si vedeva in quelle acque da circa 16 anni. A Palermo e Catania, invece, è stata la foca monaca a fare capolino dal mare. Per saperne di più su questa specie mediterranea a lungo minacciata, rimandiamo al prossimo numero di Lapilli+, in cui troverai brani e foto tratti da uno splendido libro fotografico realizzato dal collettivo di fotografi naturalisti The Wild Line. Nella newsletter scoprirai perché le foche monache sono state a lungo sull'orlo dell'estinzione e perché gli esperti sono ora più fiduciosi riguardo a una loro possibile ripresa. Non perdertela! E se non l'hai ancora fatto, assicurati di aggiungere Lapilli+ alle newsletter che ricevi e di passare a Lapilli premium.

L'immagine di copertina di questo mese è un nostro adattamento della foto “Date Palm Plantation” di Tomas Tarvainis.

GUIA BAGGI
Giornalista indipendente, scrive di ambiente e nello specifico della relazione tra l’uomo e il mondo che lo circonda. Negli ultimi anni si sta concentrando sugli impatti che i cambiamenti climatici e altre crisi ambientali hanno sull'area mediterranea – ma anche su iniziative legate all'adattamento. Per questo ha ideato e co-fondato Magma.Grazie per aver letto fino a qui. Ci vediamo ad aprile, o prima con Lapilli+.
Se questa newsletter ti è stata inoltrata, per continuare a riceverla puoi iscriverti qui. Lapilli è distribuita gratuitamente e sempre lo sarà, ma puoi sostenerci destinando il tuo 5x1000 a Magma Aps (C.F. 96511280586) o con una piccola donazione (anche con bonifico intestato ad Associazione Magma APS, Iban: IT34B0623002812000030639558), grazie!
Lapilli è la newsletter che raccoglie ogni mese notizie e approfondimenti su ambiente e Mediterraneo apparsi sui media e selezionati da Magma.